Rivista_Mediconadir_presentazione
3 >>> 4 >>> 5
“Pirrere e pirriaturi” antichi mestieri di Favignana, l’isola farfalla
a cura di Cinzia Ferrari
Appena la si comincia a scoprire addentrandosi in bicicletta per strade e sentieri Favignana ci parla della sua storia antica, del lavoro duro e faticoso della sua gente. Le “pirrere”, le sue cave a cielo aperto, sono infatti testimonianza di un mestiere che per secoli ha rappresentato una fonte di sostentamento per la popolazione dell’isola.

Foto 1: cave di tufo a cielo aperto
Il tufo, così semplicemente chiamato, è in realtà una calcarenite quaternaria ricca di fossili che ne
testimoniano l’origine marina.
Le prime cave furono molto probabilmente scavate da Romani e Fenici e le diverse popolazioni che si sono susseguite sull’isola, compresi gli arabi,proseguirono questa attività fino alla seconda metà del novecento quando l’introduzione del più economico mattone forato ha portato alla sostituzione dei blocchi di calcarenite.
Foto 2: fossile di conchiglia
Il tufo estratto infatti veniva utilizzato per la costruzione delle case degli isolani ed esportato in
tutto il mediterraneo dove era apprezzato per la sua consistenza e bellezza. Sono di tufo di Favignana molte abitazioni di Trapani, di Tunisi, della Messina ricostruita dopo il terremoto del 1908, monumenti e ville di Palermo come le stesse della famiglia Florio.
Quando si ammirano queste bellezze non ci si deve dimenticare del duro lavoro dei “pirriaturi”, che
dall’alba al tramonto tagliavano, staccavano, caricavano e trasportavano blocchi di tufo delle dimensioni di 25 per 25 per 50 centimetri: i “cantuna”. Dopo aver individuato il punto dove il tufo era consistente e solido, la cosiddetta vena buona, i pirriaturi cominciavano ad incidere il contorno del blocco con la mannara, una specie di piccozza con la lama larga e con il manico piatto.
Successivamente con lo “zappune” e il “piccune” staccavano il blocco a volte aiutandosi con lo stesso manico della mannara per fare leva.
Foto 3: gli arnesi del cavatore, piccune, zappune e mannara
La prima fila di blocchi veniva tagliata verticalmente in modo tale da sondare uno strato più profondo e nello stesso tempo crearsi lo spazio per poter scendere.
Man mano che la cava si approfondiva e che i pirriaturi scendevano scavavano nella parete gli “scanneddi”, appigli che avrebbero consentito la risalita non poco faticosa se si pensa che le pareti erano a strapiombo se non in contropendenza.
Ovviamente appena lo spazio creatosi lo consentiva si costruivano dei veri e propri gradini molto più agevoli. Durante la discesa nella parete venivano piantati dei pioli che fungevano da gancio sia
per i vestiti che per il pranzo frugale che il pirriaturo si portava da casa e che il più delle volte era
rappresentato da prodotti semplici e tipici della realtà isolana quali pezzetti di tonno essiccato, prodotti dell’orto e alcuni fichi.
Foto 4: scanneddi per la risalita
I cantoni estratti venivano caricati su carri trainati da animali e il mastro pirriaturo incideva nella parete una tacca per ogni carro che usciva pieno dalla cava cosicché la sera era in grado di quantificare l’estrazione dell’intera giornata: una sorta di vera e propria contabilità.
Il tufo veniva trasportato in tutta l’isola e venduto per la costruzione delle case ma anche trasportato al mare per essere caricato su imbarcazioni chiamati “schifazzi” che partivano per raggiungere tutte le coste del mediterraneo.
Ancora oggi sia da terra che dal mare si possono vedere i resti di questi scivoli, anch’essi di pietra, di imbarco del tufo chiamati “scari” dai quali si facevano scendere i blocchi fino alle imbarcazioni.
Passeggiando in queste cave non si può non restare ammirati dalla maestria con la quale persone
semplici, e il più delle volte con bassa scolarizzazione, riuscissero a plasmare questa roccia creando archi, grotte e tunnel in barba alla più raffinata architettura e rispettando l’armonia dell’isola che gli forniva questa grande risorsa.
 Foto 5: Scari di accesso al mare
Foto 5: Scari di accesso al mare
Attualmente sull’isola di Favignana è attiva una sola cava sfruttata meccanicamente e non più con i
vecchi strumenti del pirriaturo. Le restanti rimangono comunque a ricordo di un’attività fiorente in passato e sono state in alcuni casi trasformate in veri e propri giardini ipogei sfruttando la falda d’acqua dolce che scorre piuttosto superficialmente sotto l’ala orientale di questa
bellissima farfalla posata sul mare.
Foto 6: veduta dei giardini ipogei
(Un ringraziamento particolare a Maria Gabriella e Ancilla per avermi fatto conoscere questo antico
mestiere e a tutti i favignanesi che con la loro immensa ospitalità mi hanno fatto amare questa
bellissima isola tutt’altro che misteriosa agli occhi di chi la sa ammirare).
Cinzia
 L'affettività deve essere sempre con noi.
L'affettività deve essere sempre con noi.
A cura di Simona Marchese
Cari amici,
con grande entusiasmo son a scrivervi ciò che è emerso dall'incontro con Luisa
e Paolo della associazione NADIR che è avvenuto
mercoledì 15 aprile 2009 al Torrazza.
Erano presenti: Simona, Giuseppe, Daniele, Anna, Annalisa, Marco, Roberta
Scoccimarro, Massimiliano, Mara, Pietro e Alfredo.
Ci sono molti modi di guardare l'affettività sotto tutti i suoi aspetti: essa una
cosa personale, che si esprime in maniera diversa a seconda del proprio
carattere. E' come una “valigetta” che ognuno si porta con sé in cui mette
dentro le persone che ritiene giuste per lui, a seconda di quello che gli danno.
Cos'è l'affettività?
È un sentimento basilare per costruire un certo rapporto umano.
Però bisogna stare molto attenti perché a volte lo confondiamo con il rapporto d'amore. L'amore è
una cosa più profonda. Si può vivere anche senza sostituirlo all'amicizia e altro.
In fine, con molta tristezza, sono a dirvi che purtroppo l'incontro è stato uno solo.
Siccome questi incontri sono sempre più positivi, vi chiedo anche a nome degli altri amici, di farne
uno al mese, come in passato, perché ci aiuta a vivere meglio.
Simona
Giovanna Arrico
Plaza Major _ Madrid 2009
3 >>> 4 >>> 5
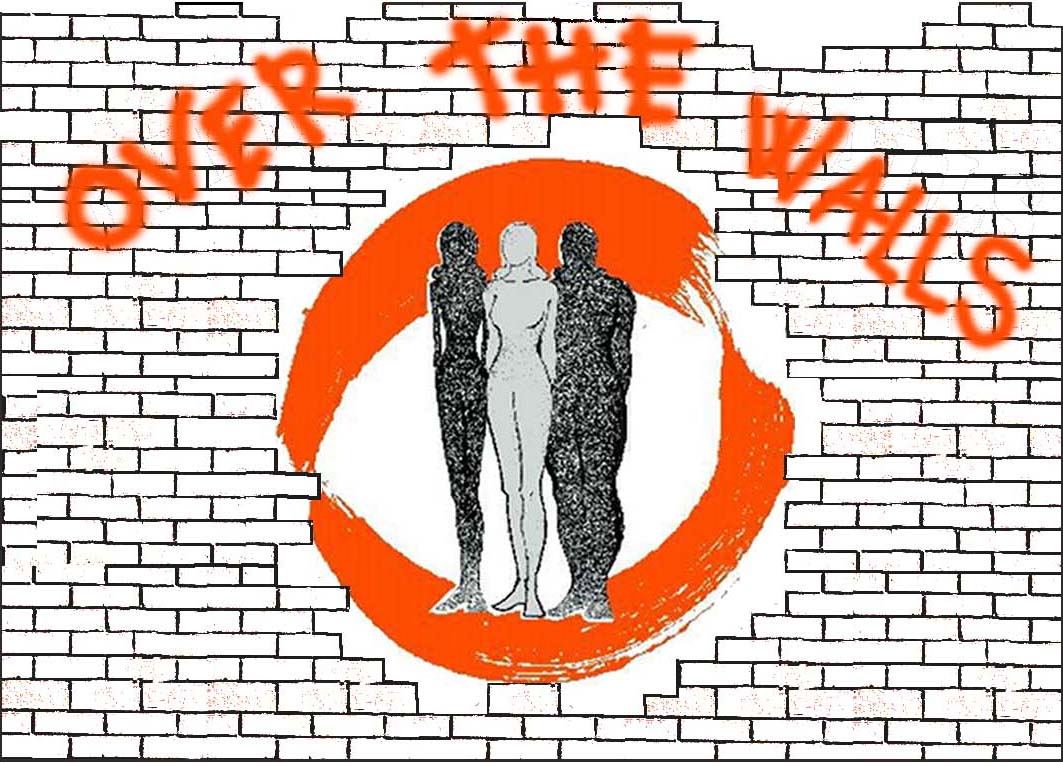








.jpg)
